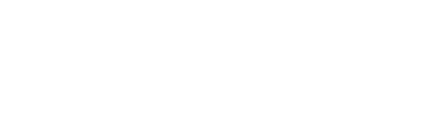Bazzano, 26/01/17. A chi piacciono i last minute ecco un invito che fa per loro (e che abbiamo appena conosciuto…): domani sera, 27 gennaio 2017, in occasione della Giorno della Memoria si potrà avere l’occasione di vedere uno spettacolo di danze ebraiche e di letture animate a cura degli alunni delle classi V della Scuola Primaria di Bazzano in Valsamoggia (Bo).

Valsamoggia Big Band, il concerto a Casalecchio
Fotografie di un concerto
Il 15 dicembre 2016 il gruppo Valsamoggia Big Band, diretta dal maestro William Monti, ha tenuto un concerto al Teatro Laura Betti di Casalecchio (Bo).

Nessun dorma – Le donne della Casa delle Donne
Arrivo un po’ prima dell’ora prevista. Suono il campanello, dichiaro il mio nome e mi fanno salire. Le scale sono quelle delle vecchie case bolognesi in cui anche l’odore di chiuso e la penombra si confonde. Sono davanti alla porta indicata e suono. Nulla. Vado al piano di sopra, dove c’è un secondo appartamento e una ragazza apre, appena, la porta lasciando un solo centimetro di luce fra me e lei; mi rendo conto di quanto sia difficile difendersi e questa condizione rende sospettosi chi lavora in quei luoghi.

Battagliero, l’inno musicale emiliano e l’ocarina dell’ Osteria del Mandolino
Alcuni hanno affermato che il brano che vi presentiamo in questo video dovrebbe essere eletto come l’inno musicale dell’Emilia; non per nulla il suo autore, Tienno Pataccini, lo ha chiamato “Battagliero”, noi di Millecolline lo abbiamo impiegato, nella versione dell’Osteria del Mandolino, come colonna sonora dei videoclip di A t’al dèg! e potremmo essere d’accordo.

Pillola Corsara n.26 – Dobbiamo salvare la lingua italiana
Mi auguro che questa lettera sia solo un “modello” pubblicitario per far capire le esagerazioni giustificate dalla moda corrente di sentirsi “in”, se si scrive e si parla inglese. Una lingua incomprensibile, di un’ altra geografia culturale e priva di ogni sensibilità espressiva ed estetica come quella italiana. Un augurio che oltre al consumare “prodotti” italiani, si ritorni a parlare solo la lingua italiana ed i “forestierismi” siano solo dei personali “optional”. Superiamo la pigrizia che è il virus di molte malattie sociali e culturali del nostro tempo.

Dove sono in inverno quelli delle Ariette?
Abbiamo deciso di fare questo spettacolo per parlare dell’oggi – scrive il regista Stefano Pasquini che con Paola Berselli è anche autore del testo – e per parlare dell’oggi abbiamo pensato di raccontare una storia di molti anni fa, quando avevo 17 anni. È la storia di una piccola odissea personale fatta di incontri, di scoperte, di sconfitte e di viaggi, da Bologna alla Francia e dalla Francia al Mediterraneo, alla Spagna, all’Algeria.